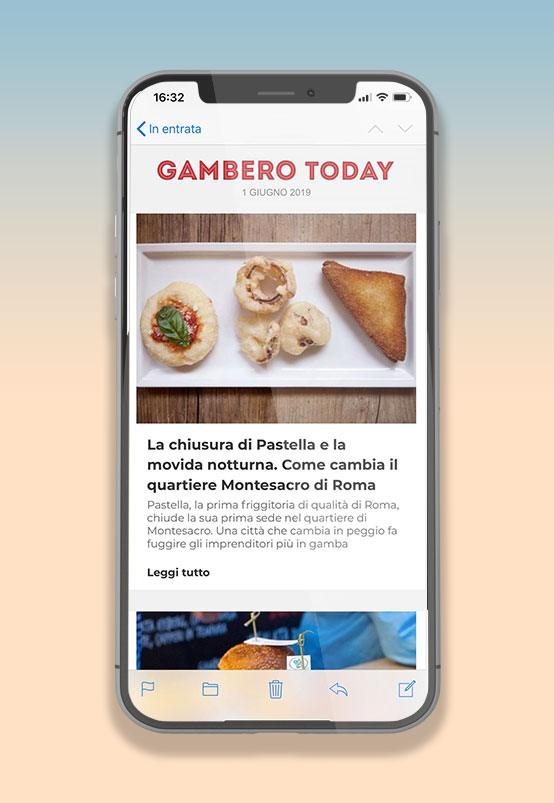Poteva essere una classica storia di passaggio generazionale: Giuliana, la figlia, che torna al paese e e prende in mano la trattoria della mamma continuando a proporre i piatti storici in un contesto più raffinato e di design, e con vini più ricercati. Invece il ritorno a San Piero, frazione di Bagno di Romagna, è stato qualcosa di più. Giuliana Saragoni e Moreno, suo marito, hanno riscritto la storia della cultura materiale di uno dei luoghi più intriganti d'Italia, quella dell'Appennino Tosco-Romagnolo, della loro gente, dei loro territori. “Lavoravo all'ufficio cultura di Forlì” racconta Giuliana, che a fine agosto porrà termine a questa avventura iniziata nel 1951: perché la Locanda al Gambero Rosso, dopo oltre sessant'anni e dopo aver conquistato i palati di mezzo mondo, chiuderà tra qualche settimana i battenti. “Ma nel '92, con la malattia di mio padre, decisi di andare in pensione e tornare a San Piero, e prendere in mano la trattoria della mamma. Lei voleva farmi stare in sala, ma io adoravo cucinare, da sempre. Però, non volevo continuare a fare i piatti che cucinava lei. Così insieme a Moreno, mio marito, abbiamo cominciato a ricercare i piatti di casa, quelli che mangiavamo da bambini...”
Quando arriva Giuliana, l'Osteria originaria era stata trasformata in Trattoria. Prima i contadini e i commercianti salivano a San Piero portando le loro cose da mangiare e si fermavano a bere il vino della casa. Poi, con l'avvento del benessere che segna la sconfitta della civiltà contadina e offre una disponibilità di prodotti prima impensabile, mamma Diva comincia a cucinare: “Il giovedì, ad esempio, si faceva la trippa in bianco, una sua ricetta, e la gente veniva apposta per mangiarla. Poi, quando si sono liberati gli appartamenti al piano superiore, la mamma li ha trasformati in Locanda”racconta Giuliana. “Con il benessere, la gente ha cercato di cancellare le ricette della tradizione familiare anche per rimuovere le proprie origini povere e dimostrare che si poteva permettere piatti che prima non poteva mangiare”spiega Moreno “la cucina della festa abbiamo cominciato a mangiarla tutti i giorni. Io e Giuliana ci siamo resi conto che i miei suoceri avevano trasformato la loro cucina avvicinandola a quello che era il nuovo benessere”.
Sarà stato il lavoro presso l'ufficio cultura, sarà stato il desiderio di mettere un po' di sé in un'attività che ormai sembrava diretta verso un futuro già scritto, ma è proprio in questa considerazione che si inserisce la nuova storia di Giuliana. “Ho voluto riscoprire i sapori della memoria e i prodotti di questo territorio: la farinata di grano o la minestra di castagne e fagioli che si mangiavano da bambini, in casa, erano ormai scomparsi. Al principio era difficile presentare questi piatti: era l'epoca della carne e non si usavano più. Così ho iniziato a proporli come entrate, come piatti di benvenuto che offrivo io. Poi sono stati gli stessi ospiti a chiedermeli e così li ho potuti mettere in menu. Oggi facciamo i tortelli con i fiori di acacia e i cappelletti con i fiori di sambuco, saltati con pomodoro fresco o con gli stridoli. Ricordo che i più venivano soprattutto per vedere la ristrutturazione del locale. Ma quando è uscito il primo articolo di Gianni Mura e dopo, con gli articoli sulle guide gastronomiche, la nostra clientela si è allargata e ora abbiamo molti ospiti che vengono a trovarci apposta dall'estero».
Moreno, oltre alla ricerca storica dei piatti, va a cercare tutte le erbe nella stagione giusta. “Tutti i piatti scomparsi che abbiamo riportato alla luce rappresentavano qualcosa in cui la gente non si riconosceva più”sorride lui “la grande intuizione di Giuliana è stata proprio riportare alla luce quel mangiare che rappresentava e rappresenta la vera cucina del territorio: determinata nei sapori proprio dagli ingredienti che si trovavano solo lì, attorno a casa”. Qual è stato il piatto più difficile da ritrovare o da ricostruire? “Teniamo molto alla nostra zuppa di erbe spontanee,legata alla ricerca delle erbe che si trovano nei campi in un determinato momento. Chi viveva dalle nostre parti in inverno mangiava tutte cose grasse, anche per combattere il freddo: carni insaccate, grasso e formaggi stagionati. In primavera c'era il bisogno di ripulire il fisico da tutte le tossine accumulate e questa zuppa era uno dei piatti che servivano proprio a resettare l'organismo. Era la zuppa che si faceva in casa. Ed è stato il piatto più difficile: dipende tutto dalla capacità di cercare e trovare le erbe e dal sapere quali utilizzare. Io ricordavo quella che faceva mia nonna, ma abbiamo parlato con tante persone di una certa età che si ricordavano le erbe. Su questa zuppa ci sarebbe molto da scrivere. Io la definisco un multivitaminico, l'equivalente delle pillole che ingeriamo oggi per integrare sali e vitamine. Si ripuliva l'organismo, ma si arricchiva anche delle sostanze importanti”.
Giuliana, insieme ai sapori, ha messo in tavola ha anche delle storie. “Il mio ruolo è stato quello di ricostruire queste storie”racconta Moreno “mi sono documentato e ho letto molti testi, dai libri di Massimo Montanari a quelli di Piero Camporesi, grandi studiosi dell'alimentazione. Sono risalito al perché venivano fatti questi piatti, perché si sviluppava un certo modo di mangiare. Trasportare queste cose al tavolo è un compito importante, spiegare e far capire cosa c'è dietro a ciò che si mangia”.
Giuliana ora è stanca, ha un problema alle gambe, il medico le ha vietato di continuare a stare in piedi in cucina. Così, dalla fine di agosto e dopo una serie di serate in cui verranno ripercorsi tutti i piatti storici della Locanda, il Gambero Rosso chiude i battenti. Una domanda viene naturale: perché non continua Michela? “Lei è bravissima in sala, quando manca tutti la cercano. Ma non si è formata per stare in cucina. Suo marito, Paolo, è una persona d'oro: è stato fondamentale nel ricercare e trovare piccoli produttori che ci hanno sempre assicurato prodotti eccezionali. Ma io non posso più cucinare. In cucina, accanto a me, c'è Alina: una donna speciale, ma anche lei non se la sente più. Avrei dovuto mettere un'altra persona in cucina, ma non sarebbe più stata la stessa cosa. La Locanda al Gambero Rosso sarebbe stata comunque una storia passata”. E così, per non dimenticare la storia e la sapienza di Giuliana e di Moreno, per non permettere che si ripeta ciò che è accaduto ai piatti dimenticati che loro hanno riportato in vita, i due protagonisti della Locanda continueranno a insegnare, a trasmettere la loro esperienza ai giovani, ai nuovi cuochi: saranno infatti nella squadra delle Scuole di cucina del Gambero Rosso a Roma. Perché le nuove leve non dimentichino le migliori radici del passato e il futuro non sia una cosa priva di vita e di spessore.
Un esempio ce lo dà con due piatti, che raccontano l'evoluzione della società: la Polpetta di nonna Diva, piatto storico della Locanda che Giuliana ha appreso da sua mamma; e la Zuppa di erbe spontanee: “La mamma la faceva in casa, non in trattoria. Io l'ho ripresa e l'ho arricchita con una pasta imperiale fatta a modo mio” racconta la cuoca. Le polpette, piatto storico, un classico della riscoperta della cucina povera, sono in realtà figlie della generazione del boom. Le polpette sono uno dei piatti possibili grazie alla grande disponibilità di carne che ha segnato il passaggio dal dopoguerra agli anni '60. Per Giuliana, ma anche per Michela, per Paolo e per Moreno, sono state un punto di partenza: da lì, per andare avanti sono dovuti tutti tornare indietro. E la Zuppa di erbe spontanee è il piatto che ben marca questo passaggio e che contiene in sé lunghi secoli di storia e di cultura materiale. Sembrano – oggi – piatti figli di una stessa cultura, invece no. Le vere radici sono nella zuppa, nella cucina di necessità dove è fondamentale trovare intorno a casa gli ingredienti per sopravvivere nel modo migliore, quelli che davvero segnavano il passaggio delle stagioni. Giuliana, questa zuppa l'arricchisce con una pasta imperiale molto sostanziosa, ma povera e di territorio al tempo stesso. È il ricordo dei cubetti di pane rosolato che spesso si mettevano nella zuppa, quando il pane raffermo era già una ricchezza. “Oggi molti la fanno utilizzando il semolino, io invece impasto insieme la ricotta dell'Appennino, uova, noce moscata e Parmigiano: stendo tutto, cuocio metto al forno e poi ne faccio dei cubetti che vanno nella zuppa che così si nobilita ancor di più senza tradire radici e territorio”. Insistiamo per avere la ricetta di questa pasta imperiale, ma Giuliana si nasconde dietro al suo irresistibile sorriso: “Questa è una ricetta speciale, ci tengo molto... Voglio essere io a trasmetterla direttamente ai ragazzi e agli appassionati che vorranno venire a seguire le mie lezioni alla Città del gusto. Ci tengo troppo, voglio essere io a raccontarla!”.
Zuppa di erbe spontanee
Ingredienti per 4 persone:
400-500 g di erbe di campo (radicchi di campo, rosole, cicerbite o crespigni, stridoli, aspragine,ecc…)
30 g di finocchio selvatico (solo foglie e gambi molto teneri)
1 patata media
2 cipolle medie (circa 150 g)
aglio tritato (facoltativo)
50 g circa di olio extravergine di oliva
1 litro di acqua circa
sale grosso
pane casereccio tostato a dadini (o dadini di Pasta Imperiale)
Nettare le erbe eliminando residui terrosi e foglie non fresche, lavarle abbondantemente risciacquando fino a che l’acqua non resti limpida. Tenerle a bagno, in acqua fredda o con ghiaccio, con un po’ di bicarbonato (per la disinfezione) per circa 15/20 minuti.
Pelare la patata e tagliarla a pezzi grossolani.
Scaldare l’olio in una casseruola, aggiungere e far imbiondire la cipolla tritata. Unire i tocchetti di patata, aggiungere acqua e far cuocere per circa 10 minuti aggiustando di sale, quindi aggiungere le erbe scolate e il finocchio selvatico e salare col sale grosso.
Aggiungere l’acqua fino a ricoprire il contenuto e rimescolare.
Portare a bollitura a fiamma alta per poi proseguire la cottura a media fiamma per circa 10 minuti aggiungendo, se occorre, un po’ d’acqua. A fine cottura aggiustare di sale, quindi lavorare il composto al mixer per frantumare finemente anche il finocchio selvatico. Servire in un piatto fondo con un pugno di dadini di pane casereccio tostato, un po’ di olio (una croce d’olio, si diceva un tempo, a sottolineare la parsimonia con cui si usava e la sacralità che si attribuiva all’extravergine) e un ciuffetto di finocchio selvatico al centro.
Al posto del pane, Giuliana usa spesso dadini di Pasta Imperiale (impasto di uova e formaggio pecorino con sale, pepe e noce moscata passati al forno che compongono un altro piatto tradizionale della festa: la zuppa imperiale). Così, dà originalità e nobiltà alla zuppa povera in un felice connubio fra cucina di tutti i giorni e della festa.
a cura di Stefano Polacchi

 Giuliana Saragoni e Moreno hanno studiato e riportato in vita le tradizioni, non solo gastronomiche, di quella parte di Appennino Tosco-Romagnolo vicino a Bagno di Romagna. Ora la loro Locanda del Gambero Rosso – storico Tre Gamberi – sta per chiudere, ma continueranno a trasmettere la loro conoscenza, le storie, le ricette, la cultura alle Scuole di cucina del Gambero Rosso. E già promettono una ricetta, quella di una particolare pasta imperiale.
Giuliana Saragoni e Moreno hanno studiato e riportato in vita le tradizioni, non solo gastronomiche, di quella parte di Appennino Tosco-Romagnolo vicino a Bagno di Romagna. Ora la loro Locanda del Gambero Rosso – storico Tre Gamberi – sta per chiudere, ma continueranno a trasmettere la loro conoscenza, le storie, le ricette, la cultura alle Scuole di cucina del Gambero Rosso. E già promettono una ricetta, quella di una particolare pasta imperiale.