«Meritiamo il colore. Meritiamo il fresco.» È con queste parole che si apre Cucina di Classe – Estate, il ricettario politico gratuito scritto da Francesca Bubba. Non è un ricettario nostalgico né poverista (cioè che raccontano la povertà in modo edulcorato o estetizzante, ndr), ma un progetto che rivendica il diritto alla bellezza anche per chi fatica ad arrivare a fine mese. In un tempo che ci vorrebbe soprattutto consumatori, Bubba prova a restituire complessità e forza alla cucina domestica, spesso raccontata come un gesto neutro, naturale, privo di implicazioni politiche, come accade spesso con ciò che riguarda il femminile. E invece no: c’è una disuguaglianza che si consuma tre volte al giorno, a ogni pasto, e che ha radici in un sistema che scarica sulle famiglie, e in particolare sulle madri, la responsabilità di colmare il divario nutrizionale.
Francesca Bubba, nata nel 1993 è un’attivista, scrittrice e madre. Si occupa di maternità, lotta di classe e diritti sociali. Tra i suoi progetti: il libro Preparati a spingere (Rizzoli), il podcast Le forme della maternità, il ricettario Cucina di Classe e la piattaforma Condivisione è cura, che promuove solidarietà tra genitori.

«Meritiamo il colore. Meritiamo il fresco.» Hai scritto così nel tuo ultimo ricettario. Cosa significa oggi, per una persona che fatica ad arrivare a fine mese, cucinare con orgoglio?
Significa reclamare qualcosa che è stato sottratto a chi arriva a fine mese a stento: il diritto alla bellezza, al sapore, alla cura e alla ricerca. Quando si è stanchi, con pochi soldi e poco tempo, cucinare diventa soprattutto una fatica. Ma se quell’atto, invece che di sopravvivenza, si tinge di colore, freschezza e dignità, allora diventa una piccola rivolta. È dire: non mi vergogno, non mi nascondo, risparmiare non mi costringerà a rinunciare ai colori, alla bellezza, al profumo d’estate. È cura, è politica, è respiro.
Cosa ti infastidisce di più del modo in cui il mondo enogastronomico racconta (o ignora) la povertà?
Mi infastidisce il fatto che spesso parla di povertà senza ascoltarla, senza entrare davvero nelle sue pieghe. O peggio: la trasforma in estetica, in nostalgia da copertina, con il cucchiaio di legno e il grembiule della nonna. Ma la povertà non è romantica, è fatta di conti in rosso, di scontrini letti due volte, di figli a cui vuoi dare tutto senza far pesare nulla. Mi infastidisce che il racconto sia ancora così distante dalla realtà, e che chi cucina con poco venga giudicato, compatito, o ignorato.
Le tue ricette non sono “poveriste” né nostalgiche. Parlano di politica. Hai mai ricevuto critiche per questa scelta?
Sì, più di una volta. Mi hanno detto che la cucina dev’essere leggera, che parlare di classe sociale rovina l’appetito. Ma io penso che sia proprio lì, nella materia viva del cibo, che le disuguaglianze si vedono nitide. Nella società capitalista, il consumo alimentare diventa questione di merito individuale: chi compra “bio” è elogiato, chi frequenta i discount è colpevolizzato. Questa retorica è classista e ignora la realtà di milioni di famiglie che lottano per garantire pasti dignitosi. Questa è totalmente una questione politica.
A chi ti rivolgi quando scrivi? E chi ti senti di disturbare, se c’è qualcuno che vuoi disturbare con quello che fai?
Mi rivolgo a chi sta nel mezzo del caos, che sia una madre, un giovane precario, una persona sola. A chi ha creduto per anni che il suo risparmiare fosse svuotato di significato e forza politica. Disturbo chi pensa che mangiare bene sia un privilegio e non un diritto, chi si sente al sicuro nel giudicare le scelte di consumo di chi risparmia. Nonostante l’apparente crescita di interesse per l’alimentazione vegetale sui social, i dati mostrano un calo nella vendita di prodotti ortofrutticoli, con famiglie costrette a preferire alimenti più sazianti, considerando frutta e verdura come superflue. Il problema non è chi risparmia sul cibo, ma un sistema che rende necessario farlo. Criticare scelte alimentari economiche senza analizzare le cause strutturali significa ignorare sfruttamento e speculazione. Spero che, scrivendo a chiare lettere cosa si cela dietro scelte alimentari socialmente percepite come deprecabili, qualcuno abbia cambiato idea. E sono certa di sì, perché ho molta fiducia nelle persone.
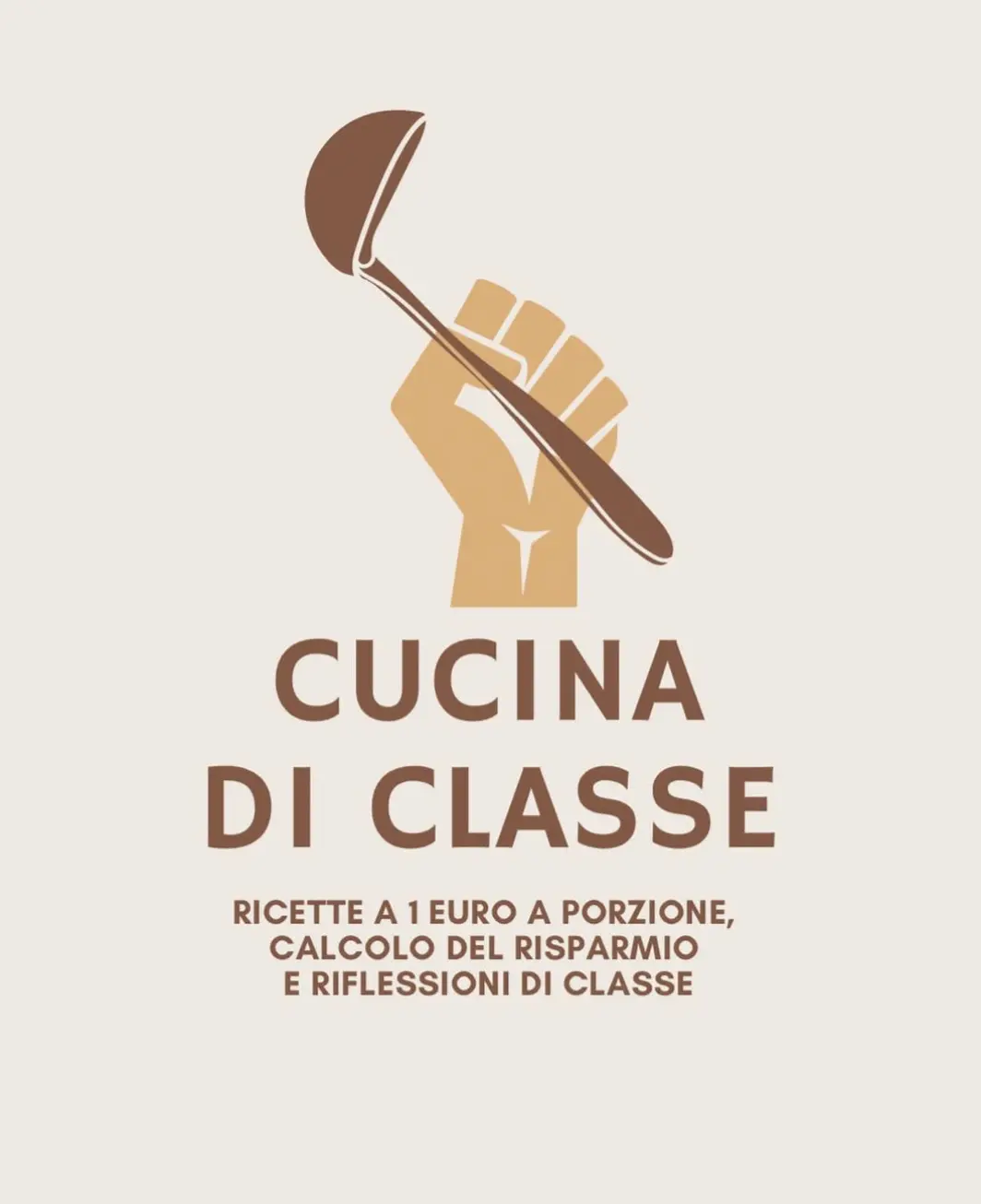
Cucina di classe
Quanto è importante per te distinguere tra cucina popolare e cucina povera? E quanto è importante invece rivendicare la parola “povertà”?
Distinguere è fondamentale. La cucina popolare è sapienza, condivisione, resistenza. È un sapere collettivo che attraversa generazioni, che custodisce radici e territori. La cucina povera, invece, è una condizione. È l’assenza, è la scelta negata, è il piatto che non basta. Ma per troppo tempo la parola “povertà” è stata rimossa, nascosta sotto nomi più rassicuranti. Io credo invece che vada pronunciata, rivendicata senza storture. Perché non è la povertà a essere vergognosa. È vergognosa la disuguaglianza che la genera. Rivendicarla senza investirla di romanticismo ci consente di appropriarcene, restituendole la dignità che contiene.
In Cucina di Classe – Estate scegli di proporre cocktail analcolici. Dici che l’alcol può essere una barriera economica, sociale e culturale. Quanto è classista la convivialità oggi, anche in cucina?
La convivialità oggi è spesso un lusso. È l’abbonamento al delivery, la cena gourmet, il brunch da 30 euro. È il vino “naturale” da degustare, ma solo se hai la lingua e il portafoglio giusti. In questo sistema, chi non beve o non può bere – per scelta, per salute, per religione, per trauma, per soldi – resta fuori. Invisibile. Inadeguato. Con i cocktail analcolici ho voluto rompere un codice. Dimostrare che il piacere non è proprietà privata. Che si può brindare con dignità.
In Italia, spesso il discorso sul “cibo per tutti” si ferma al volontariato o alla beneficenza. Tu parli invece di diritto, di accessibilità, di desiderio. Cosa manca ancora per cambiare paradigma?
Manca il coraggio di dire che non basta più fare del bene. Che la beneficenza, da sola, non libera nessuno. Che servono politiche, investimenti, ascolto. E che, a un problema sistemico, non si può rispondere con una misura emergenziale calata dall’alto. La dignità non si concede: si riconosce. Non possiamo accontentarci di garantire il necessario, dobbiamo garantire anche il desiderabile, quando si tratta di un tema così profondamente permeante come la cucina. Io sogno mense curate, dispense dignitose. Spazi dove chiunque possa scegliere, assaggiare, imparare. Perché il diritto al cibo non è solo sopravvivenza. È accesso alla bellezza, al gusto, al piacere di nutrirsi e saziarsi.
Ti definisci attivista, non influencer. In che modo usi i social per fare attivismo e non solo comunicazione? E quanto costa – in termini emotivi, economici, personali – tenere aperto uno spazio accessibile e gratuito come il tuo?
Uso i social per parlare a chi di solito non viene interpellato. Per raccontare ciò che resta fuori dai grandi media: ciò che accade nelle case delle persone comuni.
Non vendo prodotti, non promuovo brand, non alimento il senso di frustrazione in chi mi legge, ma provo a prendermene cura. Promuovo possibilità, e cerco di nutrire la necessità dell’essere umano a fare comunità. Oggi più che mai siamo sommersi da immagini di lusso ostentato sui social. Molte influencer condividono perfezione, presentandola non come qualcosa di eccezionale, ma come fosse la normalità, alla portata di tutti. Anche se forse inconsapevole, questo messaggio pesa su chi fa fatica a coprire i bisogni essenziali, generando frustrazione, senso di inadeguatezza e solitudine.
Quando si diventa madri, il legame con il cibo si complica: ci si aspetta che tu nutra, che tu sappia cosa cucinare, che tu lo faccia con amore e magari pure con creatività. Perché questo fardello ce lo prendiamo ancora quasi sempre noi? E come si fa a spezzare questo automatismo?
Perché la società continua a dire che se non cucini, non ami abbastanza. Che se il tuo bambino mangia male, è colpa tua. Che se non hai tempo, sei sbagliata. E noi ci crediamo, ci affanniamo, cercando di sopravvivere in un crescente senso di insufficienza. Finché molte di noi si perdono, questa è la verità. Perché la frustrazione trova molti modi, spesso drammatici, di manifestarsi e scompaginare tutto ciò che abbiamo creato.
Per spezzare questo meccanismo serve disobbedienza. Serve guardarsi allo specchio e dire: sto facendo il meglio che posso. Serve chiedere aiuto. Accettare che l’amore non si misura in quantità di verdure biologiche servite a tavola. Ma si misura nella presenza, nella pazienza, nella cura anche verso sé stesse.
Una domanda più personale: che cosa cucini quando hai davvero bisogno di sentirti bene?
Una pasta semplice. Olio, aglio, magari un po’ di pane grattugiato tostato. Roba da niente. Ma dentro quel piatto c’è tutto: la cucina di mia nonna, i pomeriggi d’infanzia, il profumo della salvezza. Mi ricorda che la felicità può essere un piatto caldo e che può provenire dalle mie mani.
E quando la cucino, mi sento intera. Umana. Viva.
Niente da mostrare
Reset© Gambero Rosso SPA 2025 – Tutti i diritti riservati
P.lva 06051141007
Codice SDI: RWB54P8
registrazione n. 94/2021 Tribunale di Roma
Modifica impostazioni cookie
Privacy: Responsabile della Protezione dei dati personali – Gambero Rosso S.p.A. – via Ottavio Gasparri 13/17 – 00152, Roma, email: [email protected]
Resta aggiornato sulle novità del mondo dell’enogastronomia! Iscriviti alle newsletter di Gambero Rosso.
Made with love by
Programmatic Advertising Ltd
© Gambero Rosso SPA – Tutti i diritti riservati.
Made with love by Programmatic Advertising Ltd