E se l’agricoltura – intesa come rapporto diretto tra uomo e terra per poterla abitare, coltivare e farla fiorire – fosse più una questione di convivenza che non un “semplice” modo di procurarsi il cibo? Partiamo da qui, da quale sia il senso dell’agricoltura oggi nell’Italia moderna, per provare a tracciare con Alfonso Pascale, studioso e dirigente di organizzazioni professionali, una storia dell’agricoltura in Italia con l’obiettivo di disegnarne un possibile futuro.
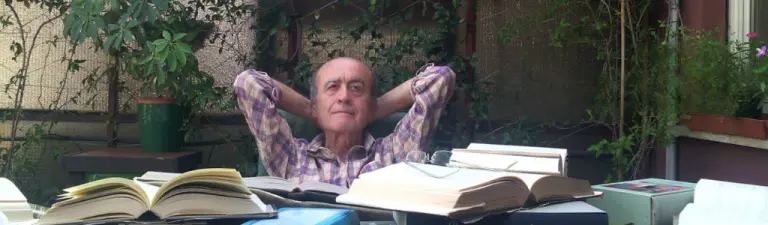
Alfonso Pascale
C’è una immagine, nella lunga chiacchierata con Pascale, che dà bene l’idea di quale possa essere il valore di un mondo oggi troppo spesso relegato ai margini della modernità. «In un borgo abbandonato della riforma agraria, Taccone di Irsina, in provincia di Matera, nel “rovente” 1977 la Costituente contadina, che stava dando vita alla Confcoltivatori (oggi Cia, ndr), organizzò una manifestazione di tre giorni sul tema “occupazione giovanile e sviluppo dell’agricoltura”: parteciparono 2mila giovani che provenivano da tutta Italia, soprattutto dalle università, da quei luoghi in cui – nelle città – quegli stessi giovani aggredivano Luciano Lama e si scontravano con la polizia e con altri giovani di opinioni opposte. Quegli stessi giovani stettero lì, accampati nelle loro tende, per 3 interi giorni a discutere, a confrontarsi e a riflettere pacificamente insieme ai rappresentanti delle organizzazioni contadine su come poteva nascere una nuova agricoltura favorendo l’ingresso di giovani che provenivano da culture non legate al lavoro della terra». Mentre nelle città si sparava e si picchiava, in campagna ci si confrontava. Perché?

«Partiamo da una considerazione – inizia la sua “lezione” al tavolino di un bar romano a Tor Pignattara Alfonso Pascale –. L’agricoltura non nasce per produrre cibo: per un lungo periodo il rapporto tra numero di abitanti del pianeta, terra e quantità di cibo disponibile attraverso la caccia, la pesca e la raccolta di vegetali spontanei è stato in equilibrio. Successivamente, per migliaia di anni raccolta di frutti spontanei e coltivazione di specie addomesticate sono coesistite. E nel tempo la prima è diminuita nella misura in cui è cresciuta l’importanza dell’altra. L’agricoltura nasce come attività dell’uomo per adattare la terra e le acque a forme più civili di convivenza umana. L’uomo, a un certo punto della sua evoluzione, avverte il bisogno di fermarsi e di costruire comunità stanziali. L’agricoltura fu lo strumento che poteva accompagnare e rendere possibile quella evoluzione. Lavorare la terra per adattarla a un insediamento umano stanziale è conservare le risorse, rendere il territorio più stabile».
Un pezzo di storia che è il centro ossessivo della vita e della riflessione di uno dei più brillanti e outsider intellettuali del Novecento, Bruce Chatwin.

«Partendo da lì – continua Pascale – si può vedere come storicamente il rapporto tra cibo e agricoltura sia diventato sempre più importante con la modernità, con la crescita della popolazione e con la rivoluzione industriale. È a quel punto che l’agricoltura ha dovuto accrescere la propria produttività, con la meccanizzazione, la chimica e la genetica. E così si è sviluppata, da una parte, l’industria produttrice di mezzi tecnici per l’agricoltura e, dall’altra, l’industria di trasformazione dei prodotti agricoli. Se è prevalentemente l’agroalimentare, oggi, a produrre il cibo per una popolazione che ha superato gli otto miliardi di individui, resta da ragionare e riflettere sulla funzione primaria dell’agricoltura, la sua funzione culturale e sociale, cioè quella di costruire relazioni e comunità: questo tema è stato esplorato solo in minima parte».

Come conciliare, però, agricoltura in quanto pratica della terra e tecnologia che è base del processo industriale e che ormai è la parte più importante nella produzione del cibo?
«Proprio in questo l’agricoltura può avere un ruolo e un senso importante di riequilibrio. La tecnologia ha un’importanza fondamentale per il settore agroalimentare e per l’insieme della società. Ma se la funzione primaria dell’agricoltura è costruire relazioni e fare comunità, l’agricoltura deve inverare e trasmettere quelle culture agricole, accumulate da millenni e che sono alla base delle nostre società, per fare in modo che lo sviluppo tecnologico abbia al centro l’uomo, la sua dignità e il suo bisogno di giustizia. Se andiamo a vedere le nostre storie individuali, tutti siamo eredi di culture agricole, che ci derivano da antenati contadini o proprietari terrieri. Il problema è come queste culture possono essere vivificate e rese utili per affrontare la contemporaneità e guardare al futuro con ragionevoli speranze».
Sembra facile parlandone al tavolino di un bar… «Ecco, purtroppo oggi manca un pensiero sull’agricoltura che andrebbe elaborato in ambito interdisciplinare con filosofi, storici, antropologi, sociologi, urbanisti e scienziati per capire come l’agricoltura può contribuire oggi a migliorare le nostre società, a difendere le nostre democrazie e le nostre libertà e a creare un mondo più giusto e sostenibile. La mancanza di questo pensiero è oggi alla base di tutte le incertezze e le contraddizioni che si vivono nel rapporto tra agricoltura e società».

È abbastanza straniante vedere come ormai si confonda l’agroalimentare (industria e simili) con l’agricoltura e come nella vita quotidiana ci sia sempre meno contatto tra uomo e terra… «C’è una crisi di ruolo dell’agricoltura. È questa la maggiore criticità del mondo agricolo che è rimasto in mezzo al guado».
Quale guado? E come si è aperta questa frattura tra società civile, quotidianità e agricoltura che fino a pochi decenni fa era normale e diremmo anche ovvia? «La frattura comincia a diventare profonda dagli anni Settanta del secolo scorso quando termina il grande esodo agricolo. Un esodo che ha avuto però diverse letture interpretative: quella che si è maggiormente affermata ha visto la fuga dei contadini dalle campagne verso le città come la fine dell’agricoltura e la dissoluzione della cultura agricola. Era invece l’esito naturale di un processo sociale ed economico innescato dalla Riforma agraria (che rompeva il latifondo), dagli interventi per la formazione della proprietà coltivatrice e dalle opere infrastrutturali (bonifiche e irrigazioni) realizzate dalla Cassa del Mezzogiorno. Un processo in cui l’agricoltura si è potuta modernizzare, installandosi su una proprietà più diffusa della terra che ha permesso a tanti contadini di trasformarsi in imprenditori. Un processo che portava già scritto in sé lo svuotamento delle campagne. E sarebbe stato illusorio pensare di scansare quell’evento doloroso. L’arrivo dei trattori, dei fitofarmaci e dei fertilizzanti faceva cadere la domanda di manodopera. E i piccoli fazzoletti di terra venivano ineludibilmente abbandonati. Ma senza una riduzione degli addetti non sarebbe stato possibile ottenere una crescita della produttività in agricoltura e un innalzamento dei redditi agricoli».

Eppure l’Italia aveva il fior fiore degli studiosi e intellettuali della terra… «La Riforma agraria e l’esplosione della Rivoluzione Verde avevano portato all’agricoltura moderna, non alla fine dell’agricoltura. I massimi esponenti della cultura agronomica ed economico-agraria – da Giuseppe Medici a Manlio Rossi-Doria, da Giuseppe Orlando a Giuseppe Barbero – erano ben consapevoli che quel processo doveva essere accompagnato seriamente, ma prevalse l’interpretazione riduttiva di un’agricoltura che andava in esaurimento. E così a interrompere bruscamente quel processo fu l’idea dell’industrializzazione forzata dall’alto come panacea dei mali del Sud. La svolta “industrialista” – proposta dalla Svimez nel 1953 – venne condivisa trasversalmente da tutti i partiti e da tutti i sindacati. E nel 1957 diventò legge. Con motivazioni solo parzialmente diverse, tutti temevano il dramma dell’emigrazione di massa verso il triangolo industriale. Ma la preoccupazione non riguardava solo i forti disagi sociali indotti da quella prospettiva, bensì anche gli imprevedibili mutamenti politici. La Dc vedeva nell’insediamento dell’industria di Stato al Sud un’opportunità per garantirsi il consenso mediante le assunzioni clientelari. Mentre il Pci vedeva nella nascita di una classe operaia meridionale l’elemento decisivo per insediarsi più stabilmente tra le popolazioni».

Un’occasione persa in nome di un interesse di parte, dunque? «Ci fu anche questo elemento nell’adesione alla proposta Svimez. Le voci che si levano contro quell’idea furono diverse: Olivetti, Rossi-Doria, Dolci, Ceriani-Sebregondi e Ardigò. Ma tali voci furono messe a tacere. E nel momento in cui la proposta divenne la grande scelta strategica per il Sud, si delegittimava e marginalizzava un’intera cultura economica, sociale e politica fondata sullo sviluppo endogeno e partecipativo. Veniva, in sostanza, scartata l’idea di articolare l’intervento pubblico attraverso una maturazione guidata dalla ricerca sociologica sul campo e dai processi educativi e formativi. La società è così progredita sul piano economico e sociale, ma non si è avuto un suo sviluppo effettivo ed equilibrato. È da lì che l’agricoltura rimane in mezzo al guado».
Noi stiamo parlando di Italia. Ma cosa ha di diverso questo Paese rispetto al resto dell’Europa? Perché altrove lo scenario sembra essersi evoluto diversamente… «C’è un dato che andrebbe approfondito seriamente, per capire e per pensare a un futuro. Nel 1957 l’Istat registra per la prima volta il calo degli addetti all’agricoltura sotto il 50% della forza lavoro attiva. E nel 1963 esplode quello che conosciamo come boom economico: in quei 5 anni milioni di persone si spostano dalla campagna verso le città e dal Sud al Nord. Si trattò di un processo che negli altri Paesi europei (penso all’Inghilterra e poi a Francia e Germania) si è diluito in oltre un secolo mentre in Italia avviene in pochi anni».
«La trasformazione dell’Italia da Paese prevalentemente agricolo a Paese prevalentemente industriale non ha dato luogo a fenomeni di sradicamento e di alienazione che si sono verificati altrove, in altri contesti sociali e storici. Come ha osservato Franco Ferrarotti, da noi la cultura contadina ha fornito quella base d’identità e quella sorta di ammortizzatore segreto delle crisi sociali ad ampio raggio che ha permesso una trasformazione senza particolari traumi. Nelle Marche, in Umbria e in Toscana, per esempio, molti mezzadri sono diventati piccoli e medi imprenditori protagonisti dei cosiddetti distretti industriali. Se si vanno a leggere le “storie di vita” raccolte tra i contadini meridionali che raggiungono il triangolo industriale per farsi operai nelle fabbriche o impiegati negli uffici, vediamo che essi hanno rotto gli schemi del mito della fabbrica fordista come motore di civiltà e della città come luogo armonico dove l’uomo trova il suo equilibrio. E invece, in quei racconti si scopre che si possono avere i piedi in fabbrica alla catena di montaggio o in un ufficio dietro ad un computer, ma gli schemi mentali prevalenti sono ancora fermi al “paese mio”, immersi nella cultura del borgo d’origine, chiusi nel suo controllo sociale».
«Per decenni, in agosto, gli ex contadini sono tornati coi pullman per un mese nei paesi da cui erano partiti. È stato un rito a cui almeno due generazioni non hanno rinunciato. Un modo per continuare a vivere la cultura agricola nella società industriale. Qui a Tor Pignattara per esempio – sorride Pascale – così come negli altri quartieri di Roma, le borgate sono state costruite da ex contadini emigrati da altre province del Lazio e dalle regioni meridionali che si portavano dietro la loro cultura agricola: da borgate questi quartieri oggi sono diventati la parte più vitale della città, non si percepiscono più come periferia perché il centro non esiste più, è solo turismo e deserto abitativo: la vita sta nelle ex borgate!»

Così, però, sopravvive solo un gancio culturale e storico, ma il rapporto tra campagna e città, tra tecnologia e agricoltura non si accentua ancora di più? «Certo che sì. Ed è una grande conquista la modernizzazione dell’agricoltura. Essa si è alimentata per lungo tempo di un rapporto molto stretto tra agricoltori e cultura agronomica ed economico-agraria. E a consolidare tale relazione tra conoscenza esperienziale e conoscenza scientifica emerge, fin dalla seconda metà dell’Ottocento, il ruolo centrale dello Stato sia per quanto riguarda l’istruzione agraria che per quanto concerne la ricerca, la sperimentazione e la divulgazione delle innovazioni agrarie. Questo ruolo centrale dello stato si mantiene saldo fino alla seconda metà degli anni ‘50».
Con lo spostamento del baricentro della politica economica nazionale dall’agricoltura all’industria, «si ha un fatto gravissimo poco indagato dagli studi storici. Si riduce sempre di più il sostegno all’istruzione agraria e in generale al sistema pubblico della conoscenza agricola. La gran parte dei tecnici che escono dalle scuole e dalle facoltà di agraria vengono assunti in misura maggiore rispetto al passato nelle industrie produttrici di mezzi tecnici (macchine, concimi, mangimi, ecc.) per l’agricoltura e sono adibiti alle attività di assistenza tecnica e di divulgazione agli acquirenti. E così gli agricoltori diventano destinatari passivi di tecnologie senza potersi giovare di strutture pubbliche capaci di fare da filtro nel rapporto tra questi e le industrie produttrici di mezzi tecnici. È da allora che viene a mancare un rapporto paritario e biunivoco tra agricoltura e conoscenza scientifica. Il venir meno progressivamente di un impegno pubblico nella trasmissione del progresso tecnico e nelle politiche territoriali costituisce una delle cause di fondo della rottura dell’equilibrio tra visione produttivistica dell’attività agricola e visione conservativa delle risorse ambientali. Una rottura originata dall’erosione progressiva delle relazioni interpersonali nelle campagne e dalla solitudine in cui è lasciato l’agricoltore. La rottura ecologica è essenzialmente una frattura della conoscenza e da qui prende il via il percorso della perdita di senso e di ruolo del settore agricolo».

Però di lì a breve anche l’entusiasmo per il progresso e per le meraviglie della vita urbana entreranno in crisi… «Sì, tanto che negli anni ‘70 avviene un processo inverso all’esodo: comincia una sorta di controesodo». Ovvero, ci riagganciamo con l’immagine con cui abbiamo aperto questo articolo… «Nel ’77 si approva la 285 che contiene anche dei capitoli sulla possibilità di costituire cooperative agricole giovanili su terre di proprietà pubbliche: da quelle esperienze nascono le prime forme di agricoltura biologica e di ospitalità agrituristica».
Erano anni di fermenti, di contestazioni… Si metteva in discussione l’esistente e si cercavano trasformazioni… «Ecco, questo movimento che interessa il mondo agricolo si incrocia con quello degli operatori sociali alla ricerca di forme alternative ai manicomi nel trattamento della sanità mentale. La Legge Basaglia è del ‘78. Nascono così le prime forme di agricoltura sociale: si torna a quei valori sociali che l’agricoltura aveva in parte smarrito. Le nuove agricolture che prendono forma hanno in sé ovviamente la produzione di cibo ma il cibo non è il loro centro: decisive diventano le relazioni e la costruzione di comunità».
Perché, allora, questo percorso virtuoso si è interrotto o non ha funzionato? «A partire dagli anni ’80 si cominciò ad elaborare queste tematiche nel confronto tra le organizzazioni agricole, il mondo ambientalista ed esponenti della ricerca: si ponevano le basi per un rapporto tra agricoltura ed ecologia su basi scientifiche. Purtroppo, però, non ci fu la capacità di saldare rapporti e culture. L’attenzione prevalente nel Paese si era spostata sui temi dello sviluppo industriale. C’è stata incomprensione».
Una “incomprensione” che – secondo Pascale – ha origine in diversi “vizi” e “scorciatoie” maturate soprattutto a Sinistra. «Cominciamo a dire che i movimenti ambientalisti non nascono a sinistra, ma storicamente a destra e in origine sono movimenti anti modernisti. Poi, sì, arrivano anche a sinistra: però vengono vissuti più come tendenze e mode da seguire per adeguarsi; la sinistra non riesce a interpretare questi movimenti alla luce della propria storia, bensì come una cultura che pone al centro nuovi conflitti sociali da utilizzare come sostituti del vecchio conflitto di classe. Non nasce un dialogo tra i movimenti ambientalisti e una cultura agricola che sta cominciando ad affrontare i temi della ricomposizione tra modernizzazione ed equilibri ecologici. Si arriva così, nel 1990, in un clima di incomunicabilità, ai referendum sulla caccia e sull’utilizzo dei fitofarmaci che non raggiungono il quorum e poi, nel ‘92, a quello che abolirà il ministero dell’Agricoltura: così il fossato diventa una barriera. Il referendum del ‘92 venne proposto dalle Regioni e fece esplodere una vera e propria crisi di rappresentanza dell’agricoltura. È stato quello l’apice della crisi del rapporto tra agricoltura e società».
Sono quelli anche gli anni in cui succedono cose politicamente rilevanti: per esempio il fallimento di Federconsorzi che era il regno di Coldiretti e Confagricoltura. Una crisi che ha segnato profondamente la rappresentanza agricola fino ad arrivare oggi all’inserimento della locuzione “sovranità alimentare” nella denominazione del ministero delle Politiche agricole. Insomma, l’agricoltura torna in primo piano… «No, direi proprio di no. O almeno, non ancora. Il caso della Federconsorzi è proprio il segno della diversità italiana: segna quale sia stato il livello dello scontro politico sulle campagne in Italia. Qui, per esempio, a differenza che in tutti gli altri grandi Paesi europei, la rappresentanza del mondo agricolo è frammentata in una molteplicità di organizzazioni. Questa è una caratteristica assolutamente italiana e continua a segnare la nostra storia». Parliamone un po’, prima di chiudere questa prima rassegna sulla storia agricola italiana per poi tornarci su con l’analisi delle vicende più legate all’attualità…
«L’anomalia italiana è determinata dal fatto che, a differenza di tutti gli altri grandi Paesi europei, la sinistra non nasce nelle fabbriche e nelle città, ma nasce nelle campagne: le prime forme associative e politiche nascono nelle campagne. Questa specificità va collegata alle antiche tradizioni civili del mondo contadino del Mediterraneo. Ai riti di ospitalità o alle veglie nelle serate invernali o allo scambio di mano d’opera o all’idea di vicinato legata ad una reciprocità di diritti e doveri tra persone che abitano terre o case contigue. Erano forme concrete di relazionalità con cui gli individui si aiutavano vicendevolmente. Il faticoso passaggio dalla spontaneità all’organizzazione è favorito dall’incontro tra il movimento dal basso dei contadini e l’opera di propaganda dei primi “apostoli” del socialismo. La Federterra nasce nel 1901 prima della Cgil che sarà costituita nel 1904. E in quel congresso si consuma il primo scontro ideologico tra due visioni di rappresentanza contadina. La prima prefigura un’organizzazione prettamente bracciantile. L’altra aperta anche ai ceti intermedi, ai mezzadri, affittuari, compartecipanti, coloni e piccoli proprietari coltivatori. La soluzione trovata è però ambigua: fare due sezioni distinte, a patto che tutti operino per la socializzazione della terra. Una parola d’ordine marxista in contrasto con le aspirazioni dei contadini. E molti, spaventati, si tengono a distanza dalla Federterra. Nel frattempo, si avvia un processo di formazione di contadini proprietari. Grazie alle rimesse degli emigrati, un flusso continuo di moneta pregiata permette a braccianti e contadini poveri di comprare circa un milione di ettari di terra. Il mondo cattolico si mobilita per organizzarli: la parola d’ordine della “Rerum Novarum” di Leone XIII è “tutti proprietari”. Dopo l’avvento del fascismo, anche a sinistra, nell’ambito di una riflessione sulla crisi della democrazia e sulle cause della dittatura, si punta il dito sulla mancanza di adeguate organizzazioni autonome delle diverse categorie sociali. Si fa strada l’idea che i “piccoli contadini” o “contadini poveri” divenuti proprietari avrebbero potuto esprimersi come una categoria con pari dignità rispetto alle altre. Nel secondo dopoguerra, una parte del mondo cattolico si pone in competizione con la sinistra nel guadagnare il consenso delle campagne, dando vita ad una organizzazione di coltivatori che s’ispira direttamente alla dottrina sociale della Chiesa. La Coldiretti non nasce, pertanto, come atto scissionistico ai danni della Cgil unitaria – come la storiografia ha finora erroneamente raccontato –, ma ai danni della Confida (l’attuale Confagricoltura). Tale operazione è all’origine della debolezza della rappresentanza del settore primario in Italia. Nei principali Paesi europei, la rappresentanza agricola si è fregiata e continua a fregiarsi di grandi e pressoché uniche organizzazioni professionali nazionali. Da noi, la “proprietà contadina” è, invece, assunta come modello socio-produttivo da privilegiare per costruire il moderno partito di massa nelle aree rurali. Tuttavia, differenziarsi dalla Confida non significa per la Coldiretti rinunciare alle intese necessarie su obiettivi di interesse comune. Entrambe le organizzazioni gestiranno insieme il grande salvadanaio e centro di potere dell’agricoltura italiana: la Federconsorzi. La Coldiretti manterrà sempre una posizione dominante, avvantaggiata dal decreto del 1948 che fissa in 100 lire (la stessa cifra dell’anteguerra) il valore nominale delle azioni per diventare soci dei consorzi agrari».
Ma come rispose la sinistra? «Settori rilevanti della sinistra rimasero fedeli all’idea di organizzare nella Cgil salariati agricoli e contadini. Ci vollero ben 10 anni perché nascesse l’Alleanza dei contadini, superando ritardi e resistenze di vario tipo: ma la Coldiretti aveva già acquisito un primato nella rappresentanza delle campagne che difficilmente poteva essere scalfito». E ora? «Se gli agricoltori vogliono superare la condizione di categoria priva di voce e di rappresentanza alle prese con una società restia a riconoscerne il ruolo – afferma Pascale – credo che occorra ripartire dai valori sociali legati alla terra. Non più la centralità della dimensione produttiva, ma la centralità della cultura agricola millenaria fondata sui valori di solidarietà e reciprocità, oggi indispensabili per ricostruire le comunità e difendere la democrazia. Altrimenti l’agricoltura finisce per consunzione di senso, diventando un ramo residuale della modernità. Ma quei valori, che costituiscono l’eredità più preziosa lasciata dal mondo agricolo alla società contemporanea, non si ritroveranno altrove: perdere l’agricoltura significa perdere il senso di noi stessi».
Niente da mostrare
Reset© Gambero Rosso SPA 2025 – Tutti i diritti riservati
P.lva 06051141007
Codice SDI: RWB54P8
registrazione n. 94/2021 Tribunale di Roma
Modifica impostazioni cookie
Privacy: Responsabile della Protezione dei dati personali – Gambero Rosso S.p.A. – via Ottavio Gasparri 13/17 – 00152, Roma, email: [email protected]
Resta aggiornato sulle novità del mondo dell’enogastronomia! Iscriviti alle newsletter di Gambero Rosso.
Made with love by
Programmatic Advertising Ltd
© Gambero Rosso SPA – Tutti i diritti riservati.
Made with love by Programmatic Advertising Ltd