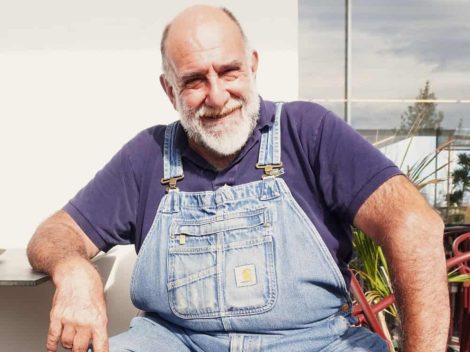Di tutta la polvere alzata dal servizio di Report con la sua ultima sortita nel settore, per molti versi abborracciata, l’unica che non si è posata immediatamente è stata quella intorno alle commissioni di degustazione. Complice chi scrive, che ha sottolineato come da diversi anni esistano nel mondo produttivo diversi atteggiamenti rispetto a questo fondamentale strumento di valutazione dei vini che aspirano ad avere il riconoscimento di una Doc o una Docg, abbiamo visto emergere visioni contrapposte rispetto al loro ruolo e financo dei disciplinari di produzione che meritano un approfondimento, perché celano la direzione che il mondo del vino ha già preso, checché ne dicano i contrapposti pasdaran.

Questo articolo è disponibile integralmente sul mensile Gambero Rosso in edicola.
Nulla di originario, molto di veronelliano
La prova di degustazione, per le Doc e le Docg, nella Legge Desana (il DPR 930 del 1963, che istituì le Denominazione di Origine in Italia, come sistema organico) era del tutto facoltativa: il disciplinare di un vino poteva (non doveva!) prevedere «la prova di degustazione, nella fase di imbottigliamento, limitatamente ai vini a denominazione di origine "controllata" e "garantita", stabilendone le modalità».
La legge Goria del 1992, all’art. 13, rende obbligatorie le prove di degustazione e fissa la composizione delle commissioni: devono essere composte da tecnici ed esperti degustatori in rappresentanza delle categorie professionali interessate alla produzione e commercializzazione dei vini.
Di quell’impianto abbiamo oggi il distillato, nel Testo Unico del 2016, all’art. 65.
Che cosa fa una commissione di degustazione? Assaggia un vino che ha già superato la verifica analitica strumentale dei parametri previsti dal disciplinare (alcol, acidità, estratto secco non riduttore, acidità volatile) e attraverso l’esame visivo, olfattivo e gustativo stabilisce se il vino corrisponde o no a quanto previsto da un disciplinare.
Tutto bene e tutto chiaro? Insomma, no
Prendiamo un disciplinare a caso, quello della Doc Spoleto. Ecco i “parametri”. «Colore: giallo paglierino; odore: vinoso, caratteristico; sapore: secco, talvolta acidulo». Un vino che ha odore vinoso oppure caratteristico, quanto spazio lascia all’interpretazione della commissione? Eufemisticamente, vere e proprie praterie ermeneutiche.
E allora su cosa si baserà la commissione di degustazione per dire che il naso di certi vini di cui ha ben scritto proprio sul Gambero Rosso Sonia Ricci, non è vinoso o non è caratteristico o non ha il gusto secco o acidulo? Farà semplicemente di testa propria. E qui casca l’asino.

Le commissioni e il manganello
Le vere finalità delle commissioni di degustazione sembra collegarsi all’italica passione per il manganello. Le commissioni di degustazione NON sono state create per essere arbitro in terra del bene e del male, checché ne dicano certi fautori dell’ordine e della repressione della varietà espressiva.
Le commissioni di degustazione sono state create con la possibilità di declassare che Veronelli invocava come sola salus, affinché i vini che non arrivavano a un minimo standard di qualità potessero essere risparmiati al bicchiere e alla bocca dell’ignaro consumatore. Dunque, non per fissare un obbiettivo qualitativo, per di più senza alcun appiglio nella lettera del disciplinare; non per tarpare le ali all’espressione dei crû, dei “vini bandiera”, ma per assicurare che sotto una minima asticella non si rischiava di scendere se su quell’etichetta campeggiava una Doc o una Docg: non un massimo da raggiungere, ma un minimo da assicurare.
Naturalmente, questo compito è diventato molto più agevole da svolgere quando, con il progresso tecnologico e la diffusione della cultura enologica, il livello minimo qualitativo è diventato uno standard abbordabile raggiunto senza bisogno di ricorrere alla minaccia del declassamento.
Tuttavia, è proprio in questo contesto che le commissioni hanno potuto scegliere: diventare degli orientatori produttivi (superando il mandato che la legge affidava loro ed esercitando di fatto un potere assoluto) oppure rimanere fedeli al ruolo originario. Come si è compreso, chi scrive è critico rispetto alla prima evoluzione, anche perché c’è chi ha continuato sulla seconda strada, con notevole beneficio per tutti. Sto parlando delle commissioni al lavoro sui vini Barolo e Barbaresco.
Il caso Barolo e le sfumature del dogma
Negli anni ‘90 il mondo delle colline alla destra Tanaro è percorso da fremiti che squassano la proverbiale monotonia del paesaggio e della riservatezza piemontese. I Barolo Boys fanno le loro prove, diversi sodalizi ne benedicono l’ardire innovativo e ovviamente alle commissioni di degustazione arrivano tutti, quando si tratta di chiedere l’autorizzazione a etichettare Barolo o Barbaresco Dpcg.
Dunque, cosa recitava il disciplinare dell’epoca a proposito delle caratteristiche al consumo?
L’attuale disciplinare (riformato nel 2010) indica:«Colore: rosso granato; profumo: intenso e caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico». Ma negli anni ‘90 valeva il disciplinare del 1980, il primo redatto per la Docg. Esso stabiliva: «Colore: rosso granato con riflessi arancione; odore: profumo caratteristico, etereo, gradevole, intenso; sapore: asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato, armonico». Le stesse note erano già presenti nel disciplinare del 1966.
Ebbene, per tutti gli anni ’90 ottengono la Docg i Barolo del Cavalier Accomasso come di Elio Altare; di Enzo Boglietti come di Bartolo Mascarello; di Chiara Boschis come di Teobaldo Cappellano. Erano tutti ugualmente rosso granato con riflessi arancione? Erano forse simili? Erano tutti caratterizzati dal medesimo profumo “caratteristico”? Non scherziamo.
Chi come il sottoscritto c’era, assaggiava e iniziava a scrivere, ben sa quali guerre di religione furono intraprese, nel nome, rispettivamente, del merdin e delle note di vaniglia, caffè e cioccolato…
Dunque? Dunque niente, la commissione di degustazione per quindici anni e più si è confrontata con punte di difformità rispetto a uno standard che talora, a pensar male, potrebbe addirittura aver indotto qualcuno a dubitare che nel vino non ci fosse solo uva Nebbiolo. Altro che incaricarsi di stabilire se la nuance di colore o la macerazione esorbitava da un immaginario Idealtyp…
A valle di quelle guerre di religione, cosa rimane oggi nei grandi nebbioli della destra Tanaro? Il fatto che la stragrande maggioranza dei produttori ripudia gli eccessi, alimentati da tostature estreme come da legni contaminati. Oggi, tracciare la linea fra tradizione e innovazione è diventato assai difficile perché la prima ha riconosciuto il valore della pulizia e della freschezza, mentre la seconda l’assurdità dei dogmi, come l’affinamento in barrique esclusivamente nuove.
Ebbene, la stessa cosa sta già accadendo a livello nazionale tra vini naturali e vini convenzionali, ma al completamento del percorso si oppongono due forze: l’arbitrio di certe commissioni di degustazione e l’interesse di chi sulla contrapposizione ha costruito fortune culturali e materiali.
Naturale/Convenzionale: cui prodest?
Lasciando da parte l’ormai stucchevole questione nominalistica (il vino non si fa da solo quindi non esiste il vino naturale VS il vino è il frutto di una fermentazione quindi è sempre tutto naturale), le distanze tra il mondo naturale e il mondo convenzionale si assottigliano da anni. Almeno da quando, nel 1975, Ancel e Margaret Keys nel loro “Eat well stay well. The Mediterranenan way” mettevano nero su bianco la scoperta di un trend fra i giovani, facoltosi e istruiti consumatori americani: quello dei natural wines.
Oggi sempre di più assistiamo a presentazioni di vini convenzionali che dichiarano un interventismo enologico ridotto all’osso, senza punto esservi obbligati. D’altra parte, sempre più produttori che si ascrivono al mondo del vino naturale (i cui confini incerti sono consustanziali alla sua esistenza) hanno rinunciato all’estetica che solo un decennio fa imperava: etichette sgargianti, immancabili barbe hipster su camice da boscaiolo, certo, ma anche estremismi olfattivi e gustativi fatti apposta per épater les bourgeois.
Il manifesto che solo un paio di anni fa sottoscrivevano Vini Veri e Sandro Sangiorgi, lasciando un buon numero di fan piuttosto interdetti al riguardo, era già il sintomo più evidente della realtà in movimento: nel Paese abbiamo un evidente overlapping, una feconda sovrapposizione tra i due mondi, anche se molti protagonisti non lo ammetteranno, continuando a rivendicare di fare il vino sempre allo stesso modo.
Le vere distanze tra produttori
Io lo dico senza nascondermi dietro a un dito: nella cura maniacale per la qualità dell’uva destinata a diventare vino, per la conservazione in cantina del patrimonio naturale di cui sono scrigno i grappoli, c’è oggi molta meno distanza tra Angiolino Maule e Luigi Moio, tra Alessandro Dettori e Walter Massa di quanto i rispettivi epigoni siano disposti a riconoscere.
Se partiamo da questo riconoscimento – e possiamo fare agevolmente un elenco di produttori che di primo acchito non è (più) facile ascrivere all’uno o all’altro gruppo – diventa incomprensibile che delle commissioni di degustazione che lavorano in batteria, su denominazioni spesso di recente o recentissima istituzione, prive pertanto di qualsivoglia tradizione plurigenerazionale da tutelare, sotto l’egida di disciplinari più che vaghi si accaniscano come tante Procuste sui piedi di chi magari ama semplicemente usarli per pigiare, invece delle diraspatrici.
Analogamente, non possiamo più guardare con innocenza a chi, per il proprio tornaconto, continua ad alimentare l’ignoranza (per esempio ripetendo a pappagallo cose inesatte su cosa possano fare i lieviti selezionati o maledicendo la limpidezza come segno di ignobile artefazione, mentre si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, del mero effetto di tempo, freddo e travasi ben fatti) per vendere qualche bottiglia o qualche copia in più.
Il mondo è già andato avanti, il mercato maturo del vino sta già trovando nuove forme di segmentazione, le novità sono come sempre l’attrazione principale per i neofiti del vino e, vivaddio, è giunto il tempo di non sentire più il bisogno della Santa Inquisizione o la vocazione a dividerci sempre, inutilmente, tra guelfi e ghibellini.