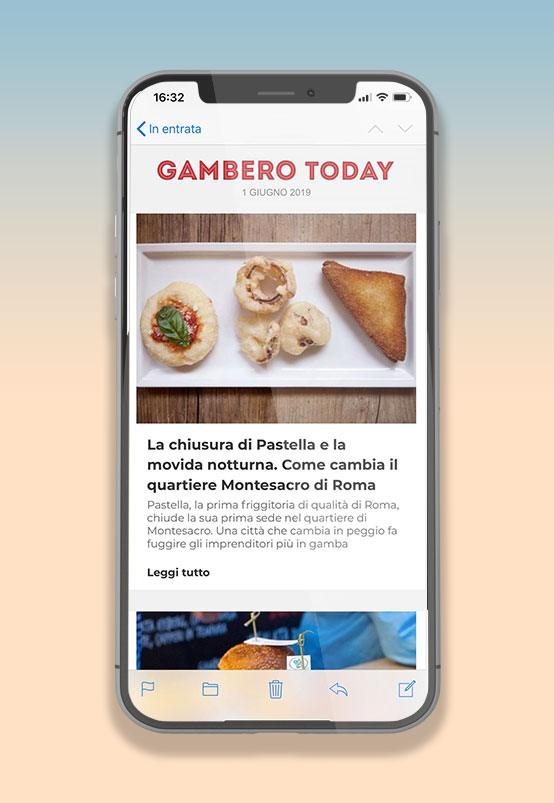L'edizione 2014 di Gastronomika apre i battenti. È quella dedicata alla cucina italiana, paese ospite di quest'anno. In realtà sarebbe meglio dire le cucine: alta e bassa, popolare, esclusiva, democratica, vecchia e nuova. Con i poli Nord e Sud invocati dallo stesso congresso. Un organismo mutevole che trova (quasi sempre) il punto di equilibrio tra le sue anime, ma che forse ancora non riesce a fare quadrato. La prima giornata ha soprattutto evidenziato l'anomalia di un paese, vecchissima storia, che non fa sistema. Ci sono gli chef, tanti, bravi, con maggiori o minori attitudini al public speech. Ci sono alcune aziende, non tantissime considerando la portata di una vetrina internazionale come questa. Non sembra che gli uni parlino con le altre, e neanche tra di loro. Ma sarebbe forse il caso, nell'Italia che si avvicina all'Expo, di diventare una squadra coesa, che lavora inseme e ragiona su come arrivare preparata all'appuntamento, in cui consorzi, ristoratori, produttori e istituzioni (a proposito, dove erano le istituzioni?) dovrebbero muoversi in blocco. Potrebbe essere, in sintesi, la parabola di un'Italia di talenti, imprenditori, uomini e donne di grande intuito, ma dove tutto viene lasciato all'iniziativa personale. Anche quando sono i migliori profili a essere chiamati in causa. E infatti a Gastronomika ognuno porta se stesso, raccontando una pluralità di voci singole, forse penalizzate dall'evasività di una chiamata che non poneva quesiti precisi. Tanto che i titoli degli interventi, le modalità di approccio, le tematiche da mettere sul tavolo sono affidate ai singoli relatori. E allora appare ancora più debole un gruppo che non si confronta e in cui l'uno non sa cosa porta l'altro.ÂÂÂ
Partenza in grande stile, con Andoni Luis Aduriz (a lui affidata l'apertura e la chiusura della prima giornata) che presenta Massimo Bottura e il suo nuovo libro. Lo chef di Modena è ormai agile nelle vesti di front man che arringa e lancia concetti con sicurezza. È l'uomo immagine di questa Italia, che mescola arte, cultura, tradizione e cristallina capacità di guardare avanti. Bottura convince, piace e fa il suo show. E lo fa con parole sue ma per bocca di Andoni. Punta sul confine tra privato e collettivo, sull'emotività di una nazione che ha i suoi miti, la Ferrari, e i suoi eroi caduti come quel Villeneuve che emozionava ma non vinceva. E qui gioca la sua carta: quella di chi ha combattuto per far capire la sua cucina e ha faticato per far riconoscere la sua posizione all'interno della tradizione. La parte croccante della lasagna, il testo letto da Andoni tratto da Never trust a skinny italian chef  (che da noi uscirà con il titolo Vieni in Italia con me) in fondo è questo. Il racconto della magia della cucina. Così Bottura illustra il suo modo di rapportarsi con la tradizione: immaginandone le prospettive future e rivedendone alcune istanze, riconoscendole il suo ruolo per superarlo. “Ho corso dei rischi, ma la tradizione è in evoluzione” dice. Si può reinventarla. E continua: “siamo sicuri che la nostra tradizione rispetti la bellezza dei nostri ingredienti? Perché insistiamo ripetendo gli errori delle nostre nonne?”. Così è il racconto del suo percorso. Nato a Modena, città “di macchine veloci e cucina lenta” in cui ha faticato per “convincere che cercavamo di salvare le tradizioni e non di scacciarle”. In fondo l'Italia vive costantemente questa dialettica a tratti soffocante con la tradizione. È tutto qui, come dice Carlo Cracco: “per un giovane cuoco italiano è complicato fare qualcosa perché c'è la tradizione, e lui deve inserirsi all'interno di questa. Questo è difficilissimo”. Cracco, veneto trapiantato a Milano, richiama la suggestione del congresso e mescola il nord del risotto con il sud dei limoni e delle mandorle per inseguire pulizia dei sapori, memore della lezione di Gualtiero Marchesi. Riportare in primo piano il gusto perché ognuno possa “riconoscere tutti i sapori della ricetta, ricomporli nella sensazione che restituisce in bocca”. Così emerge l'unicità della cucina e dei prodotti.
Ancora memoria, per Pino Cuttaia: la cucina deve essere “un colpo che tocca il cuore, il gusto e la memoria”. E si torna ancora una volta qui: alla memoria e alla tradizione, quella familiare. Fatta di ricordi, consuetudini domestiche scomposte e ricomposte dallo chef di Licata, con nuovi strumenti, ma uguali suggestioni. Il segreto per restituire quella sensazione atavica è nella perfezione stilistica, nell'impeccabile realizzazione dei contenuti, perché la tecnica è a servizio della memoria. Come il ricordo dell'acciuga arrostita ricostruito con l'espediente dell'olio leggermente affumicato, e del carbone di nero di seppia. “Ci sono due cose importanti che non dimenticheremo mai: i profumi e il gesto”. Elementi cardine da tenere sempre a mente, anche nel gioco della cucina dell'illusione. Che racconta “quello che può essere e non è”. Ma ogni escamotage deve avere un senso pieno “Non mi interessa il bello se non ha gusto” dice. Racconta il suo territorio con il Paesaggio marino. Semplice, atavico, eppure modernissimo. Il polpo con il suo contorno: l'acqua di mare, la lenticchia di Ustica disidratata e fritta che richiama la sabbia che rimane a volte nei tentacoli. E ancora una volta si parla di radici e territorio. Territorio amato, come la Senigallia di Mauro Uliassi. Genesi, ispirazione, perimetro delle sue riflessioni. C'è tutto quel che serve in quell'angolo di Adriatico. “solo in questo luogo la mia vita si poteva concretizzare” dice. E gli crediamo. Parte con il suo Bagnasciuga, e lì racconta tutto: il salmastro della battigia, l'aroma forte di una mareggiata, i detriti, la malinconica persistenza di una natura che inizia il suo decadimento. Odori forti, che avvincono chi sa consegnarsi a cuore aperto. È un piatto olfattivo, che chiama in causa “uno dei sensi che gioca più di tutti nell'esperienza del mangiare. Noi siamo quel che percepiamo con i sensi” dice “niente è più necessario dei sensi per la memoria”, altrimenti non avremmo nulla da ricordare.ÂÂÂ Impossibile non rimanere coinvolti da questo sentimentalismo delle macerie. Così come ci affidiamo all'energia, alla voglia di nuovo, che lo porta a sperimentare ogni anno, a porte chiuse, per andare oltre in un viaggio che si nutre delle sue radici e che lo porta oltre i confini. Anche oltre i confini del suo ristorante. Il progetto Uliassi Street Good è già rodato, e diventa la chiave per un altro modo di fare cucina. Semplice, solido, comprensibile, immediato riconoscibile. È lo street food che scardina le regole del servizio e avvicina quelle più spontanee del gusto, perché vìola molte regole del cibo, porta l'atto del mangiare nella sfera collettiva, in un clima di complicità. È il connotato più alto al cibo popolare. Ma è anche un progetto che riflette con lucidità su nuovi modi di fare impresa, in un'Italia sempre più in difficoltà, che pare non lasciare moto spazio ai nuovi e ai lor progetti. Vale allora la pena di sperimentare nuove formule. In strada? E così sia, purché con il massimo della qualità e una ricerca continua di nuovi strumenti. All'assaggio un panino con la porchetta sublime, preparato sei mesi fa, dice lo chef marchigiano. E poco importa se è vero oppure o solo una provocazione. Ci sono altri mezzi da utilizzare, ci sono altre strade da percorrere, altre suggestioni e altre tecniche da inglobare. “Può avere un impatto pazzesco sull'industria alimentare” dice. Facciamolo, perché potrebbe essere la nostra salvezza.
Di nuovo territorio con Gennaro Esposito, e lo fa con un guizzo filologico, “a volte le parole hanno più significati, o ne nascondono alcuni più interessanti delle parole stesse” dice e va a cercare proprio nel significato della parola “paesaggio”. Natura, uomo, tradizione, materia, creatività: questo è il paesaggio, lo dice il vocabolario. E proprio in questa ricerca linguistica emerge con chiarezza quanto il paesaggio sia cucina e la cucina paesaggio, quanto la loro evoluzione segua gli stessi bisogni e le stesse mutazioni. E quanto la cucina sia per lui territorio, una rete di prodotti e produttori che ha stretto con decisione intorno alla Torre del Saracino. “Ho scoperto che in tutti questi anni la mia ossessione era portare nei piatti il mio paesaggio” dice. "E i paesaggi sono anche energie sensoriali intense, che non voglio addomesticare". Il paesaggio è racchiuso nel prodotto da conoscere a fondo per valorizzarne la complessità, i sapori secondari. Come nel lavoro sul limone, di cui usa buccia succo e parte bianca. “Un ingrediente non è un'unica possibilità, ma tante possibilità. Bisogna lavorarci con immaginazione”. Alcuni prodotti rappresentano piaceri ed esperienze sensoriali uniche. Hanno una storia. Il richiamo è all'autenticità e il monito a noi italiani che, per primi, abbiamo falsificato i nostri prodotti.ÂÂÂ "Non li abbiamo tutelati, non ne abbiamo salvato l'identità", dice. Ultimo intervento italiano nella prima giornata è quello di Massimiliano Alajmo: semplicità, leggerezza, profondità, liquidità. In una parola fluidità. È l'acqua che è origine e meccanismo di ogni vita. Che cambia consistenze e sapori. Chiude la giornata Aduriz. Anche lui parla di memoria e di tradizioni. “la memoria si trova nella bocca. Le esperienze gustative si riutilizzano” ovvero si elaborano, diventano materiale per fare altro. Racconta di come gli spunti siano diventati piatti. Di come le suggestioni raccolte per il mondo siano state rielaborate, trasformate e siano arrivate nel ristorante. Lo racconta attraverso un video in cui mostra il prima e il dopo di ogni cosa. È di nuovo la memoria a essere chiamata in causa perché un piatto sia compiuto. Il ristorante è il luogo dove devono succedere delle cose, dove si fanno delle esperienze, perché il buono da solo è un concetto ambiguo. Cambia secondo le tradizioni e le esperienze di ognuno. Bisogna mantenere sempre uno sguardo vigile, essere critici, mettere in discussione quel che ci viene detto. Di nuovo un monito. “Cerca di non diventare mistico”, questo gli ha detto Arzak. Ma esiste una mistica delle cose che forse è bene non perdere mai.
www.sansebastiangastronomika.com
a cura di Antonella De Santis

 L'edizione 2014 di Gastronomika ospita l'Italia dalle tante cucine: alta e bassa, popolare, esclusiva, democratica, vecchia e nuova. Il fil rouge? La memoria. Memoria in quanto tradizione, legame con il territorio e punto di partenza verso l'innovazione. Ecco il report del primo giorno con gli interventi di Massimo Bottura, Carlo Cracco, Pino Cuttaia, Mauro Uliassi, Gennaro Esposito, Massimiliano Alajmo e Andoni Luis Aduriz
L'edizione 2014 di Gastronomika ospita l'Italia dalle tante cucine: alta e bassa, popolare, esclusiva, democratica, vecchia e nuova. Il fil rouge? La memoria. Memoria in quanto tradizione, legame con il territorio e punto di partenza verso l'innovazione. Ecco il report del primo giorno con gli interventi di Massimo Bottura, Carlo Cracco, Pino Cuttaia, Mauro Uliassi, Gennaro Esposito, Massimiliano Alajmo e Andoni Luis Aduriz