Smaltita la sbornia dopo i trionfi e le bocciature, le attese e le delusioni di un nuovo anno passato sotto la lente dalle guide gastronomiche (sono 47 i migliori ristoranti d'Italia secondo il Gambero Rosso), è a bocce ferme che si torna a ragionare di ristorazione, di quella svolta per lo più nell’ombra di una quotidianità operosa: «Ai giovani va detto sin da subito che il lavoro del cuoco va scelto per il piacere di farlo, perché quella clientela che un giorno siederà alle loro tavole gli permetterà di pagare stipendi e materie prime. E lo dovranno fare senza pensare al riconoscimento delle guide, che ovviamente sarà il benvenuto perché certificherà come meritevole il lavoro svolto. Ma il premio deve essere una conseguenza, non l’obiettivo di questo lavoro». A parlare è Daniel Canzian, vicepresidente dei Jeunes Restaurateurs nonché chef e patron del ristorante Daniel di Milano, Due forchette per il Gambero Rosso.
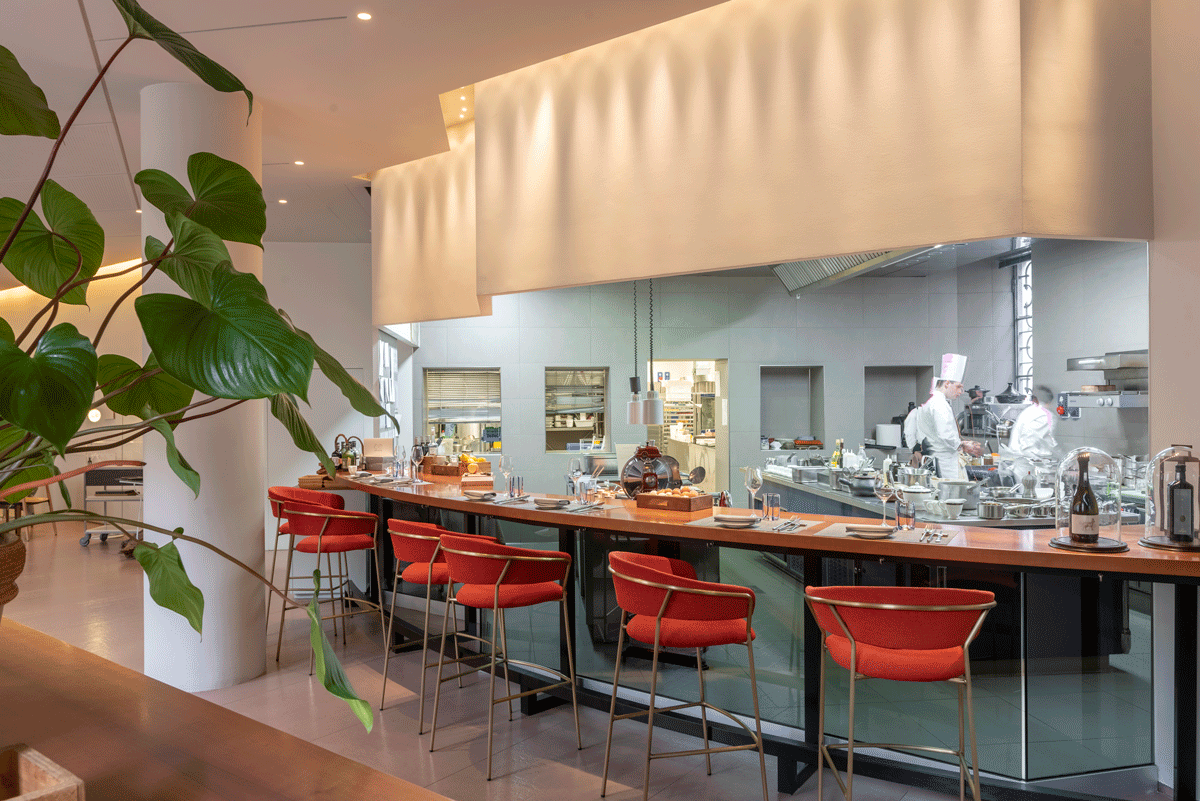
Lo chef table di Daniel Canzian. In apertura, lo chef ritratto da Gabriele Basilico
Il candidato a guidare i JRE: investire sulla formazione
Canzian oggi è candidato alla presidenza della prestigiosa associazione che riunisce quasi 400 ristoratori sparsi in 15 Paesi, cuochi che per statuto non devono aver superato i 42 anni di età, devono essere proprietari o soci del ristorante, oltre che impegnati, ovviamente, in un percorso gourmet. La ricetta da seguire, ci dice lo chef veneto formatosi nelle severe cucine di Gualtiero Marchesi, avrà per ingredienti il talento e l’impegno (parecchio quest’ultimo, seppur non a discapito della qualità della vita), insieme alle numerose competenze da apprendere perché indispensabili a chi lavora in questo mondo. E sulla cui formazione ciascuno – dal proprietario ai dipendenti – dovrà investire in prima persona.
Parafrasando il grande scrittore Carver, di cosa parliamo oggi quando parliamo di fine dining?
Comincerei col non dire che cosa non è per me il fine dining: non è per esempio prendere una fragola, frullarla, farla diventare una mousse, farmi preparare uno stampino a forma di fragola per reinserire questa mousse e poi congelarla, sformarla, gelatinizzarla, mettere dei puntini per portar quindi in tavola una finta fragola al gusto di fragola. Questa non è alta ristorazione, è voler sostituirsi a Dio. Agli occhi del pubblico il fine dining è diventato un ristorante estremo dove tutto deve essere enfatizzato all’estrema potenza al punto da diventare incomprensibile ai più. E spesso con costi e spese insostenibili.
Tornano alla mente gli stagisti del Noma di Copenhagen che hanno raccontato al New York Times di centinaia di scarabei di frutta che hanno dovuto preparare per l’intera durata del tirocinio. Come può essere preso a modello universale un ristorante che presto chiuderà perché è insostenibile, come ha dichiarato il suo chef-patron René Redzepi?
Perché noi siamo sempre alla ricerca di trend, di mode da cavalcare e questa è certo una forma di provincialismo molto ampia. Le mode però si sgonfiano, basti pensare a quella per una certa cucina spagnola o nordica. Fino a qualche anno fa dovevamo tutti andare al Nord a imparare le fermentazioni, eppure mi permetto di ricordare che il fermentato più pregiato al mondo è nato in Italia e si chiama Aceto Balsamico Tradizionale. Quanto al tema della sostenibilità, penso che un vero ristorante è da sempre sostenibile: perché è proprio dall’utilizzo che fa degli scarti che mostrerà come sa produrre ciò che gli serve per arrotondare, incassare e incrementare il suo valore.
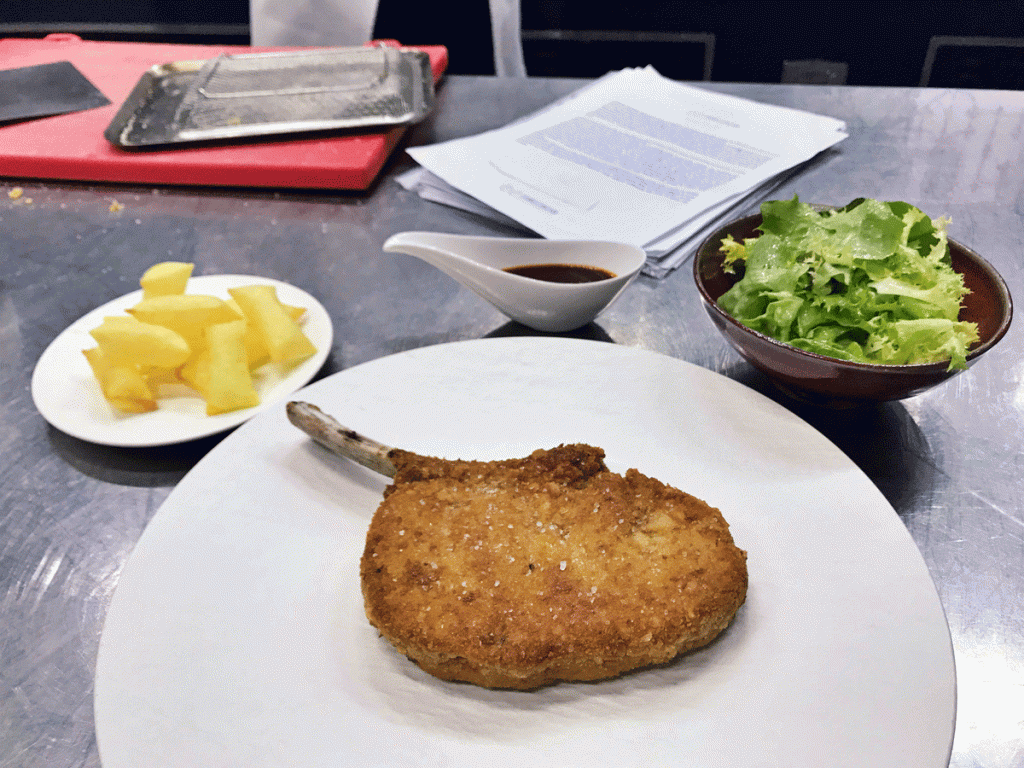
Un esempio?
Per la mia visione di cucina non voglio togliere dal menu la costoletta di vitello alla milanese. Chi è del settore sa, però, che da ogni vitello se ne ricavano solo dieci di queste costolette. Che io venderò a 45 euro l’una, a dispetto di quel critico enogastronomico che me la stroncò dicendo che era un prezzo troppo elevato per un cibo popolare come questo. Certo, se nell’immaginario comune il nostro piatto si riduce a una bistecchina impanata che non si sa se è di vitello, pollo o maiale e deve costare necessariamente poco, questo piatto è caro. Io parlo invece di un pezzo di carne largo quanto l’osso, che pesa attorno ai 250/300 grammi e che viene lavorato senza parti di nervatura e di grasso. Il 70% del vitello che non utilizzerò per la mia costoletta alla milanese io lo dovrò di certo lavorare: ne ricaverò allora un sugo d’arrosto che diventerà il protagonista del mio Risotto al limone, sugo d’arrosto e liquirizia, in carta sin dall’apertura nel 2013 e che oggi è diventato il piatto più importante del menu, grazie al quale io mi posso permettere di vendere la costoletta di vitello alla milanese al prezzo di 45 euro, perché altrimenti dovrei venderla ancora più cara.
E allora gli altri ristoranti che la vendono a meno come fanno?
Di solito la costoletta di vitello non la si trova nei grandi ristoranti milanesi. Negli altri posti invece si risparmierà sulla carne, sulla provenienza del vitello che verrà chissà da dove e che verrà tagliato a fettine sottili, senza scartare la parte di grasso che c’è attorno.
La gente comune diffida però dell’alta ristorazione, giudicandola – magari a torto – una macchina per spillare soldi, considerati i prezzi molto elevati con cui si propone. I due mondi sono destinati a non capirsi?
Credo ci sia un aspetto di educazione su cui puntare e che coinvolge anche il cliente che deve essere reso più consapevole. Prendiamo il sushi. Quello a basso costo non esiste: un chilo di salmone lo pago sì e no 10 euro, ma chi fa i conti deve riflettere sul fatto che quel salmone io l’avrò dovuto sfilettare e spellare per ricavarne una bella fettina. Il che comporterà una perdita del 60% del prodotto. E allora quei 10 euro li ripartirò sul chilo acquistato o sui quattro etti utilizzati? E senza dimenticare poi che questo mio lavoro ha un costo, a meno che non mi limiti a comprare cose di bassa qualità, già pronte, surgelate o meno, che mi limiterò a mettere nel piatto. Quando ho aperto il mio ristorante nel 2013 il primo menu degustazione costava 50 euro, vini e bevande incluse. Oggi a distanza di 10 anni Daniel si è riposizionato sul suo valore corretto avendo aumentato i servizi che dà alla clientela, clientela del resto che queste attenzioni le ha cercate, accettate, richieste e volute. E oggi il menu degustazione costa 110 euro, vini e bevande escluse.
Cerchiamo allora di definire che cosa è invece la ristorazione di qualità.
Io ammiro molto uno chef come Alain Ducasse e chi come lui fa una ristorazione di alto livello e ad alto costo, ma che è anche tangibile nel piatto e nell’eleganza del luogo in cui mi trovo a viverla. È inutile che mi si dica che sto per mangiare del caviale se poi me ne trovo un grammo nel piatto. Alta ristorazione è anche quando entro in una sala ben preparata e pulita, con del personale in grado di darmi indicazioni, che sa spiegarmi un vino e che lo sa magari fare in più lingue. Questo significa essere professionisti. Aspetti che devono essere valorizzati. Se entro in un concessionario di auto di lusso, per prima cosa chiederanno i miei desideri a proposito della macchina che voglio comprare, non mi si dirà “c’è nera o bianca”. Che un ristorante dica: “c’è il menu degustazione A o B e basta” lo posso accettare da una trattoria, meno in un ristorante di lusso.
Parlando di nuove generazioni, di giovani che vogliono lavorare nel mondo dell’alta cucina qual è secondo lei il messaggio corretto da lanciare?
Suggerirei di partire da questa considerazione: la nostra normalità è vivere nel momento in cui il nostro cliente si trova nel suo momento migliore. Quando questa sera mi vestirò da cuoco i miei ospiti si saranno preparati magari da mesi per questa cena, per festeggiare un anniversario o un evento speciale e si presenteranno da noi nella loro migliore espressione. E noi abbiamo la fortuna di stare in contatto con loro: no, a dispetto di certe voci, il nostro non è un brutto lavoro, il nostro è un bellissimo lavoro, è molto dignitoso, e certo dobbiamo conoscere due o tre lingue, dobbiamo saperci rapportare con il notaio, il calciatore, l’operaio che vuole vivere da noi una serata d’eccezione, con chiunque insomma viene a trovarci. Per questo è impossibile non applicare disciplina, studio e sacrificio alla professione che diciamo di amare.
Questo però non può più significare, oggi, che chi ambisce a lavorare in un ristorante d’eccellenza deve sacrificare se non annullare la propria vita personale.
È giustissimo, e insieme però non bisogna dimenticare che anche nel nostro lavoro vale quanto si applica in altri ambiti: se vuoi diventare dottore dovrai studiare dieci anni di università, se vuoi lavorare qui dovrai investire nell’apprendimento delle competenze necessarie a poterti poi muovere in quest’ambito. La forbice offerta dalla ristorazione è del resto molto ampia e va dal lavoro in mensa (che è sempre ristorazione) fino a realtà e figure estremamente complesse, magari nei più grandi hotel sparsi nel pianeta, che richiedono appunto competenze specifiche. Noi dobbiamo puntare a ottimizzare al massimo i tempi di lavoro senza sprecarli inutilmente. È importante che chi è alla guida del ristorante dia un messaggio di tempo libero da spendere. I miei ragazzi non devono entrare qui prima delle 9.30 della mattina e devono uscire alle 15, per rientrare verso le 17.30. A mezzanotte il ristorante deve chiudere. Noi dobbiamo creare un equilibrio tra il commensale, il nostro lavoro e la sostenibilità dell’azienda.


















