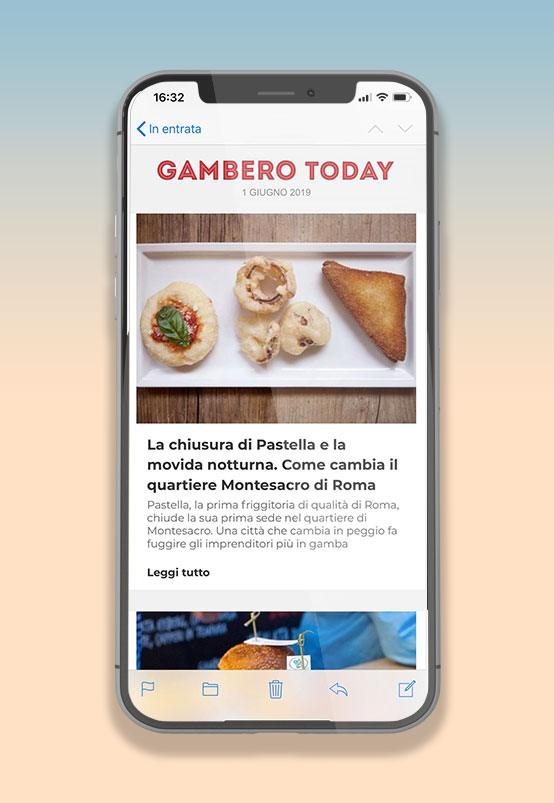Storia e territorio
Il groppello è un vitigno autoctono a bacca rossa coltivato sulla sponda bresciana del lago di Garda, nella zona che da Salò scende verso Desenzano. Le sue origini sono molto antiche e per secoli è stata una delle uve più coltivate dell’area gardesana. Fino all’800 il groppello era diffuso in un territorio che comprendeva parte della Lombardia, del Veneto e del Trentino. Tuttavia, nel reimpianto dei vigneti post-fillossera, è stato per larga parte sostituito con vitigni internazionali, salvo che in Valtènesi dove rimangono circa 400 ettari sulle morbide colline d’origine morenica dell’area bresciana del Garda, dove il clima è mediterraneo, con temperature dolci, sempre mitigate dall’influsso del lago. La vite è coltivata insieme all’ulivo, ma non mancano piante d’agrumi, capperi, agave e cactus, tipiche di latitudini più meridionali. I terreni sono costituiti prevalentemente da ciottoli e sabbie d’antichi depositi glaciali. Sono suoli poveri e molto drenanti, ideali per una viticoltura orientata alla qualità. E dove ha trovato la sua terra d'elezione il groppello. In realtà sarebbe più corretto parlare di una famiglia di uve groppello, poiché il vitigno è presente in diversi cloni e con vari nomi: il groppello di Revò, coltivato in Val di Non, il groppello Santo Stefano, che pare molto simile al groppello mocasina e il groppello gentile. Oggi l’attenzione dei produttori della Valtenèsi è soprattutto concentrata sul groppello gentile, che sta regalando i vini più eleganti e interessanti. Sono tuttavia ancora presenti vecchi vigneti con selezioni massali dalla spiccata biodiversità varietale. Il suo nome deriva dall’espressione dialettale groppo (nodo), che sta a indicare la struttura serrata del grappolo.

Caratteristiche
Il vitigno groppello produce grappoli piccoli, compatti e serrati, con acini dalla buccia molto sottile. Predilige le esposizioni soleggiate, secche e ben ventilate, che consentono di prevenire il rischio di marciumi o l’attacco della botrytis. È un’uva fragile e delicata, che va coltivata con attenzione, lasciando pochi grappoli per pianta, in modo che possano arrivare a piena maturazione con un buon equilibrio tra zuccheri e acidi. Per queste sue caratteristiche di finezza, è particolarmente adatto alla vinificazione in rosato. Insieme a barbera, sangiovese e marzemino, è utilizzato per produrre i famosi Valtenèsi Chiaretto: una denominazione che si sta affermando nel panorama italiano come una tre le migliori interpreti di questa tipologia di vini. Una vocazione che nasce da favorevoli condizioni pedoclimatiche e da una tradizione storica che risale alla fine dell’Ottocento, quando Pompeo Molmenti cominciò a produrre il vino nella tipologia rosata a Moniga del Garda. In Valtènesi le uve a bacca rossa sono appositamente coltivate per produrre vini Chiaretto come prima espressione del terroir e non come una tipologia accessoria rispetto ai rossi. Da questo punto di vista, la Valtènesi rappresenta un’eccellenza assimilabile alle Appellation francesi della Côtes du Rhône di Tavel e Lirac o di Bandol in Provenza. I rosé della Valtènesi si distinguono per una precisa identità e tipicità. Il colore è generalmente sulle note delicate del petalo di rosa chiaro. I profumi sono floreali e fruttati, con aromi fragranti di pesca, melograno, melone e piccoli frutti rossi. Il sorso è fresco e dinamico, con buona acidità e chiusura su sensazioni sapide e minerali. Nelle vinificazioni in rosso, il groppello era tradizionalmente utilizzato in taglio, perché ritenuto un vino di scarsa struttura e poco colore. Oggi molti produttori ne stanno riscoprendo le sue qualità in purezza, assecondando ed esaltando proprio la sua naturale predisposizione alla finezza e all’eleganza. Il colore è rubino chiaro e brillante, con riflessi violacei. Il bouquet esprime delicati aromi di piccoli frutti di bosco, ribes, mora e una piacevole nota speziata. Ha un corpo medio, con sorso armonioso ed equilibrato. La trama tannica è sottile e la freschezza ravvivata da un finale sapido.

Produttori
Le Aziende dell’area del Garda bresciano sono circa una cinquantina, su un territorio che non raggiunge i 1000 ettari, di cui circa 600 fanno parte della DOC Valtènesi. Per quanto riguarda il groppello vinificato in rosé, una menzione particolare va al Valtènesi Bio RosaGreendi Pasini San Giovanni, espressione in purezza di grande equilibrio e finezza. Tra i rosé prodotti con groppello in blend con barbera, sangiovese e marzemino, ci sono piaciuti il Valtènesi Chiaretto RosaMaradi Costaripa, il Valtènesi Chiaretto diGiovanni Avanzi, il Garda Classico Chiaretto di Meridiana, il Valtènesi Chiaretto Le Chiusure. Molto interessante per complessità e persistenza il Valténesi Chiaretto Molmenti di Costaripa, affinato per due anni in legno. Tra le versioni vinificate in rosso e affinate in acciaio, abbiamo apprezzato il Valtènesi Groppello di Pasini San Giovanni, il Garda Classico Groppello di Giovanni Avanzi e il Valtènesi Groppello Joel diCa’ Maiol. Chiudiamo con due interessanti versioni di groppello affinate in legno: il Valtènesi Groppello ArzanediPasini San Giovanni e il Valtènesi Groppello Maim diCostaripa.
a cura di Alessio Turazza
foto di Costaripa
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: l'erbamat clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: il nocera clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: il catarratto clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: il pigato clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: la garganega clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: la cococciola clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: il nero d’Avola clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: trebbiano di Lugana clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: la lacrima di Morro d’Alba clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: la durella clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: il carricante clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: il grechetto di Todi clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: la passerina clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: la petite arvine clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: il semidano clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: il raboso del Piave clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: il cagnulari clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: la vernaccia di Oristano clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: la nosiola clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: il frappato clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: la nascetta clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: l'asprinio d’Aversa clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: il nerello mascalese clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: il biancolella clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: il prié blanc clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: la tintilia clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: la vitovska clicca qui
Per leggere Viaggio tra i vitigni autoctoni: il timorasso clicca qui